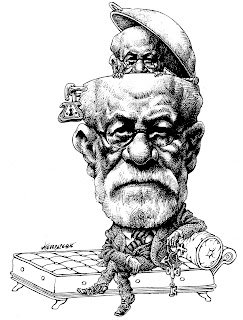(quanto segue ha costituito il nucleo centrale di un lavoro analogo risalente a qualche anno fa e mai pubblicato su QdB)
Introduzione.
Cerchi lo sguardo di
chi sta di fronte a te, e non lo trovi. Cerchi di comunicare con lui,
ma non parla. Allora, cerchi di fare qualcosa che possa essere di
gradimento ad entrambi, ma non ci riesci, non trovi nulla che faccia
al caso. Poi ti fermi a riflettere per un attimo e fai forse la più
grande scoperta della tua vita: sino a poco tempo prima credevi che
ce l’avresti fatta, che saresti riuscito, e invece ti scopri
incapace. Sembra che sia proprio questo il punto: con orrore, ti
accorgi di una limitazione, ti accorgi con vergogna che la tua
esistenza di persona capace è soltanto una finzione, che tu e chi ti
sta di fronte, probabilmente con malavoglia, avete in comune molto
più di quanto tu possa anche soltanto immaginare. Quando finalmente
riesci ad incrociare il suo sguardo, ti perdi, ti senti perso,
anneghi in quegli occhi ma non vedi te stesso, vedi un altro. Ne
ricavi una disagevole sensazione di straniamento, ti senti a disagio,
scopri che la tua efficienza è tale solo in apparenza e che la vita
umana è molto più varia di quanto potevi anche solo pensare qualche
tempo prima. Adesso che fai? Fuggi? Fai finta di niente? Cerchi di
eliminare chi standoti di fronte ti sfida, pone in questione le tue
sicurezze? Oppure ti poni un problema di non poco conto in merito al
posto che occupano nell’esistenza quelli come lui? Che, poi, è
come dire quale posto occupi ciascun essere umano. Solo adesso
assumono senso quelle parole che avevi letto anni prima:
Se un bambino
disabile viene immesso inaspettatamente in un gruppo di bambini,
tutti lo guarderanno dapprima con curiosità o stupore o sgomento,
secondo l’inesorabilità dei punti di vista. Gli unici che
conserveranno un’attenzione concentrata, una partecipazione ambigua
e un occhio torbido saranno quelli che cercano in lui uno specchio.
Alcuni, avvinti quanto sopraffatti dalla paura di riconoscersi,
reagiranno addirittura con la fuga o l’aggressività. Ma tornare è
il loro destino vischioso, la loro sconfitta rassicurante[1]
Ecco la sfida posta
in essere all’umanità dalla disabilità: fare i conti sino in
fondo con la diversità, con l’alterità.
Specchiarsi negli
occhi dei disabili, infatti, vuol dire fare esperienza della
diversità. Vuol dire immaginare anche solo per un attimo come
sarebbero potute andare le cose. Vuol dire cogliere intuitivamente
quanto vi sia di bello e di beffardo nel mistero della vita.
In ogni caso, è
come nascere una seconda volta.
2. La
disabilità.
Intento del presente
scritto è esplorare i confini dell’umano, riflettendo sul legame
che vi è tra la concezione antropologica dei disabili, la tutela dei
loro diritti e, infine, last
but not least,
giustificazione religiosa del loro essere al mondo.
Per prima cosa
occorre definire cosa sia la disabilità,
e , successivamente, stabilire “chi” sia disabile, in modo tale
da prendere in considerazione tutti i suoi possibili effetti.
Si pone, pertanto,
quasi spontaneamente, la questione di fondo: che cos’è la
disabilità? Urge darne una definizione il più accurata possibile.
Solo che, per poter parlare di qualcosa, però, è bene cominciare
dall’esperienza comune. Così, quando si pronuncia la parola
«disabili», più o meno, si possiede già una certa nozione in
mente, e si associa tale parola, generalmente, a persone con limitata
autonomia personale, con carenze cognitive, comunicative, etc.
Dunque, in prima approssimazione, sembra di doversi intendere la
«disabilità» come quella condizione, temporanea o definitiva, di
limitate potenzialità e/o abilità. In merito, la nostra
immaginazione può sbizzarrirsi, passando dai vegetativi in un letto
d’ospedale ai «deficienti» che talvolta in colonna, e in abiti
per nulla calzanti, attraversano le strade. Questa, ovviamente,
l’impressione iniziale, quella attestata dal senso comune, buono
sovente, ma non nel caso presente.
Invece, la gamma
delle disabilità, specie quelle che interessano la sfera cognitiva,
possono trovare una definizione rigorosamente diagnostica nel DSM-IV,
Diagnostic
and Statistical Manual of Mental Disorders,
il manuale diagnostico dei disordini mentali, codificato dalla North
American Association of Psichiatry.
In esso, ci si basa su una nozione comunemente accettata di sviluppo
fisiologico
delle competenze cognitive, per descrivere l’insieme dei possibili
disturbi mentali, i quali, infatti, vengono qualificati, per
l’appunto, nei termini di «disordini», ossia degli esiti
patologici nell’evoluzione mentale dei soggetti. Globalmente,
muovendosi all’interno di una prospettiva di natura medica, la
disabilità è il risultato di deviazioni patologiche dal normale
sviluppo del soggetto.
Tuttavia, per quanto
utile, e certamente interessante sotto molteplici punti di vista,
tale approccio non appare adeguato a render conto del fenomeno della
disabilità, il quale mostra diverse sfaccettature. Inoltre, è
concreto il rischio di ascriverlo ad un errato sviluppo cognitivo, il
che non è del tutto corretto, oppure non esaurisce la questione.
Infatti, sulla disabilità cognitiva possono incidere: (1) fattori
ambientali;
(2) fattori
genetici;
(3) fattori
neonatali[2].
In effetti, sul normale sviluppo delle facoltà mentali incidono
rischi ambientali inerenti alla produzione di possibili danni
permanenti o ad un’errata alimentazione oppure ancora l’esposizione
ad agenti velenosi. Nella stessa misura possono concorrere delezioni
genetiche, apportatrici di danni cromosomici permanenti tali da
impedire un normale sviluppo del soggetto. Ancora, una gravidanza
portata avanti nel miglior modo possibile non è esente dal rischio
di complicazioni poco prima, e durante, il parto, e tali da porre in
serio rischio lo sviluppo fisiologico successivo delle competenze
cognitive del nato. A tutto ciò, in qualche misura, decisamente
collegato alla nascita dei soggetti, si dovrebbe aggiungere la
possibilità di diventare disabili in un momento qualsiasi della
propria esistenza. Circostanza questa che non può essere presa in
considerazione da un manuale che fa proprio un approccio “medico”
alle disabilità. Per intenderci, vero è che le conseguenze di
determinate malattie mentali possono generare situazioni di, per così
dire, limitazioni temporanee o definitive delle proprie facoltà
mentali, ma la disabilità
è un’altra cosa.
A questo punto,
allora, si deve aggiungere che il manuale diagnostico in oggetto
venne codificato nel 1952 come risposta all’International
Statistical Classification of Diseases, Injuries and Causes of Death,
presentato nel 1948 dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità
(World
Health
Organization),
e giunto sino alla decima versione. Esso non è altro che una
classificazione dei principali disturbi che possono qualificarsi come
nocumento al normale sviluppo della persona
umana.
In genere, la classificazione si basa sull’eziologia del problema,
ossia sulla malattia
o difetto
che, a sua volta, comporta uno svantaggio del soggetto affetto
rispetto agli altri. Essa, infatti, istituisce una tripartizione
collegata tra (a) menomazione
(Impairment);
(b) disabilità
(Disability);
e, (c) handicap.
Con «menomazione» s’intende una qualsiasi perdita o anormalità
di una struttura o di una funzione, sul piano anatomico, fisiologico
e psicologico. Con «disabilità» s’intende una limitazione o
perdita della capacità di effettuare un’attività nel modo o nei
limiti considerati normali per un essere umano. Con «handicap»
s’intende una situazione di svantaggio sociale, conseguente a
menomazione e/o disabilità, che limita o impedisce l’adempimento
di un ruolo normale per un dato individuo in funzione di età, sesso,
fattori culturali e sociali.
Sembra, allora, che
proprio non si riesca a dare una definizione “in positivo” della
disabilità, dicendo cosa essa sia, e non soltanto cosa non sia. In
questa accezione, infatti, essa viene sempre considerata come una
patologia evolutiva del soggetto, un esito errato quanto
indesiderabile nello sviluppo della persona umana.
Trattandosi di una
tripartizione fortemente connotata dalla nozione di “malattia”,
nel 1999 l’OMS l’ha sostituita con l’ICF, International
Classification of Functioning, Disability and Health
(http://www.who.int/classifications/icf/en/),
una classificazione giustamente definita, e considerata,
rivoluzionaria perché non guarda più soltanto all’eziologia
medica, prendendo in considerazione soltanto i limiti nello sviluppo
del soggetto, ma perché considera la condizione
generale
di
vita
del soggetto, puntando in tal modo su “quel che egli riesce a
fare”, anziché prendere a metro di giudizio “quel che non riesce
a fare”. Così la «disabilità» viene vista come il frutto
dinamico, non statico, dell’interazione
del soggetto
con un ambiente.
In questo modo, infatti, la disabilità giunge ad avvicinarsi al
concetto inglese di «handicap», ossia di maggior peso, di origine
ambientale e/o sociale, che grava sui soggetti, ostacolandone la vita
regolare ed essendo di nocumento in tutte le attività quotidiane,
cessando di essere un limite fisico in sé del soggetto. Ciò
consente di distinguere finalmente tra la «disabilità» e il
«disabile», tra la «malattia» e la «persona» portatrice.
3. Capacità,
potenzialità, svantaggi.
Dunque, sembra di
capire come la situazione di svantaggio sia frutto di un ambiente non
in grado di accogliere la «diversità» di alcuni soggetti, di
venire incontro ai loro bisogni speciali, colpevole di non fare nulla
per rimuovere le cause materiali della differenza. Di conseguenza, il
soggetto è in minor grado, rispetto agli altri, di esprimere appieno
le proprie capacità, cognitive e sociali, denotando di conseguenza
un minor numero di potenzialità. Esiste, pertanto, un’interazione
dinamica tra le capacità del soggetto, in relazione ad un ambiente
adatto ed ospitale, le sue potenzialità future, in genere di
sviluppo ulteriore, e l’insieme degli svantaggi di cui soffre. In
ogni caso, sembra che debba essere cura della società la presa in
carico di tali soggetti in maniera tale che se ne possano ridurre gli
svantaggi.
A questo punto,
sembra di aver raggiunto una definizione soddisfacente. Pertanto, la
«disabilità» è la condizione, temporanea, come nel caso di gravi
malattie o di gravi incidenti, o definitiva, di maggior svantaggio di
dati soggetti rispetto ad altri per via di un ambiente di vita che
aumenta le difficoltà, anziché ridurle. Pertanto, quasi
conseguentemente, il «disabile» è colui che non incontra un
ambiente di vita favorevole al suo pieno sviluppo personale.
Tale definizione
marca la differenza tra ICD e ICF: il primo considera definitiva, per
quanti sforzi una società possa produrre, la condizione di
svantaggio, indicando le vie che consentano di ridurre la condizione
di minorità, mentre la seconda considera la condizione di possibile
nocumento allo sviluppo personale come un frutto ambientale. La
conseguenza è che l’handicap
va considerato non come la malattia di alcuni, ma come una condizione
di scarsa qualità della vita che interessa potenzialmente ciascuno
di noi. Come chiaramente si è recentemente espresso il Comitato
Nazionale di Bioetica:
la disabilità è
una caratteristica appartenente a tutto il genere umano[3]
Così posta la
questione, è del tutto naturale che si sviluppi la riflessione
seguente: cosa accade se una società si chiude sempre più in sé
stessa? La risposta, per quanto amara, è inevitabile: essa non terrà
conto dei bisogni personali dei vari soggetti, diversi da caso a
caso, e che vanno dalla “normalità” alla “specialità”. Cosa
comporta questo? Che, ancora una volta, i più forti troveranno un
ambiente a loro adatto, e i più deboli un ambiente ancor più
sfavorevole. Invece, sostiene Trisciuzzi:
l’handicappato non
è un fatto «esterno» alla società, ma nasce dall’esistenza di
precisi modelli culturali e sociali, e non è la scienza che
stabilisce il livello di gravità del danno, ma è sempre la società
che ne definisce i limiti, come pure fissa il grado del ricupero e
quindi dell’educabilità[4]
4. Una
sfida per la cultura, un impegno per la civiltà, un costo per la
giustizia.
La nascita di
persone disabili, prima ancora, e più, di quelle che lo diventano
nel corso degli anni, ha posto in essere anche la necessità di una
teodicea
che giustifichi la presenza dell’errore,
se così può chiamarsi, e quindi del male, così come della
sofferenza, nell’ordine della natura, un ordine che, per l’appunto,
si ritiene razionale. I greci, infatti, cui si deve la filosofia,
consideravano la natura sottoposta a ferree leggi di natura che ne
descrivevano un corso rigido e regolato. Tuttavia, anche se oggi le
cose non appaiono più negli stessi termini, resta forte
l’impressione secondo la quale non sia possibile considerare la
disabilità
la condizione normale della vita umana. Essa deve, pertanto, apparire
come un “errore” della natura che, di tanto in tanto, e per
singoli notevolmente sfortunati, sbaglia nella generazione di nuovi
individui e produce infelicità. Il problema, ad esempio, da un punto
di vista teologico potrebbe essere quello di render conto della
ragione per cui Dio permette che nascano soggetti
disabili.
Una questione, invero, affrontata in passato, senza tuttavia trovare
ad oggi una formulazione del tutto soddisfacente. In genere, ma si
tratta a ben vedere di un ragionamento che si potrebbe benissimo
generalizzare al ben più vasto problema della presenza del male nel
mondo (malum
mundi),
sono tre le possibili risposte al problema, partendo dall’assunto
teista: (a) Dio non ha alcun ruolo; (b) Dio lo vuole; (c) Dio non lo
vuole. In breve:
Dio
vuole che nascano bambini handicappati perché, mediante la loro
nascita, vuole punire (o i loro genitori o gli stessi bambini a
causa di colpe commesse in una vita precedente); 2. Dio vuole che
nascano bambini handicappati, ma non per punire, bensì per qualcosa
d’altro (insegnare, mettere alla prova, salvare); 3. Dio non vuole
che nascano bambini handicappati, ma c’è una libertà della
creazione che egli rispetta […] 4. Dio non vuole che nascano
bambini handicappati, ma, a livello naturale, non può assolutamente
nulla[5]
D’altra parte,
come non porsi il problema da un punto di vista teologico dato che
Dio dice a Geremia:
Prima di formarti
nel grembo materno, ti conoscevo, prima che tu uscissi alla luce, ti
avevo consacrato[6]
Dio consacra i
soggetti disabili in quanto vuole che nascano così? Il problema, da
un punto di vista razionale, infatti, è di difficile comprensione.
Ed ancor più se si pensa che una tale conclusione debba essere
accettata.
D’altra parte,
sempre Dio fa dire all’evangelista:
In principio era il
Verbo, e il Verbo era presso Dio e il Verbo era Dio […] tutto è
stato fatto per mezzo di lui, e senza di lui niente è stato fatto di
tutto ciò che esiste[7]
Il Verbo,
ossia la seconda persona della Trinità, Gesù il Cristo, è il
tramite tra Dio Padre e la Creazione. In quanto tale è Lógos,
nella traduzione dei Settanta, Verbum
nella vulgata
latina, insieme principio
e parola
della Creazione. È evidente l’importanza del concetto greco
adoperato, quello di lógos,
principio,
discorso,
ragione,
e che rende conto della difficoltà a tradurre in un linguaggio
speculativo le verità di fede. Tuttavia, da sempre Dio parla agli
uomini, a testimonianza del fatto che nonostante le intrinseche
debolezze umane, anche nel dare una veste linguistica accettabile
alla Rivelazione, la fede passa attraverso la comprensibilità umana,
quella per l’appunto che trova espressione mediante il lógos,
la ragionevolezza
umana.
Ma se la Creazione ha luogo attraverso il Lógos,
dunque in qualche maniera, per così dire, «razionale», come
possono avere luogo le generazioni di soggetti disabili? Forse che la
«razionalità» creatrice talvolta fa errori? O che, per ragioni
lontane dall’umana comprensione, la stessa sceglie di generare
disabili? In questo si colloca il problema teologico dei soggetti
disabili: perché Dio rende possibile una simile generazione? E come
mai a maggior ragione se si pone mente al fatto che Dio cerca in
tutti i modi di far partecipe l’uomo del Suo progetto salvifico per
il tramite della comprensione umana, di per sé limitata? Ciò
spinge, ad esempio, Mancuso a ri-tratteggiare in profondità lo
statuto della ricerca teologica, cercando di venire incontro alle
esigenze laiche:
l’interlocutore
principale di questo
libro
è la coscienza laica, laica nel senso che ricerca la verità non per
appartenere a un’istituzione, sia essa Chiesa, partito, movimento,
centro sociale, ma per se stessa, la verità in sé e per sé, la
necessitas
rationis[8]
Come Mancuso
riporta, alcune parole del famoso discorso tenuto da Benedetto XVI
all’Università di Ratisbona suonano così:
“Non agire secondo
ragione è contrario alla natura di Dio”, “Agire contro la
ragione è in contraddizione con la natura di Dio”[9]
Si sostiene, dunque,
una teologia che cerca la ragione umana. Da questo punto di vista,
pertanto, com’è possibile l’«errore» creativo dei soggetti
disabili? Forse, allora, che Dio fa differenze tra i suoi figli? Se
così fosse, non corrisponderebbe affatto all’immagine di Dio buono
che dà suo Figlio per la salvezza dell’umanità, che si fa carne e
muore come un uomo. Ma, forse, la risposta è molto più semplice,
per quanto meno attraente da un punto di vista razionale: la presenza
della disabilità dovrebbe mettere in grado di contemplare il, e di
parteciparvi, mistero
della vita.
D’altra parte, in
merito, la coscienza ebraica è maggiormente esercitata di quella
cristiana nel cercare un senso alla sofferenza umana, soprattutto
quando essa sia la più ingiustificabile perché si abbatte
sull’innocente. Infatti, così Giobbe conclude la sua odissea umana
e teologica:
comprendo che tu
puoi tutto e che nessuna cosa è impossibile per te. Chi è colui
che, senza aver scienza, può oscurare il tuo consiglio? Ho esposto
dunque senza discernimento cose troppo superiori a me, che io non
comprendo. «Ascoltami e io parlerò, io t’interrogherò e tu
istruiscimi». Io ti conoscevo per sentito dire, ma ora i miei occhi
ti vedono. Perciò mi ricredo e ne provo pentimento su polvere e
cenere[10]
Paradossalmente il
popolo veterotestamentario appare più pronto ad affrontare, sulla
base della propria cultura millenaria, le problematiche etiche.
Tuttavia, un’interpretazione teologica cristiana è possibile
ottenerla. Infatti, scrive Mancuso:
Cristo accetta la
sofferenza non per piegarla all’incremento della propria vita, ma
gratuitamente. È la sofferenza innocente, slegata cioè dal nesso
vita-morte. Tutti gli innocenti che soffrono entrano in questa stessa
dimensione, gli appartengono. Chi soffre di un dolore innocente entra
in quella dimensione dove Cristo è entrato, va a toccare il nucleo
del mistero che ci sovrasta e che ci contiene (e che ci definisce),
quel legame tra vita e morte che necessariamente crea sofferenza,
perché solo la sofferenza fa sì che dalla vita che diviene morte
nasca altra vita[11]
Dunque, che risposta
offre la teologia cristiana al problema dell’handicap? La risposta
sembra essere la seguente:
agli uomini, alcuni
dei loro figli nascono così
perché essi sono liberi; ma liberi vuol dire fragili, esposti al
nulla. L’handicap è il prezzo che si paga a una creazione libera,
lo stesso prezzo pagato dal Padre con l’immolazione del Figlio ab
origine mundi[12]
Così come
l’assistenza alle persone disabili è
una delle supreme
attività, forse la suprema in assoluto, che l’amore umano conosca.
Qui si manifesta la completa gratuità, a volte non c’è neppure un
sorriso in cambio, perché l’interessato neppure è in grado di
sorridere […] Qui si serve la vita, senza per questo produrre morte
o sofferenza altrui. E lo si può fare perché, personalmente, «ci
si perde». Proprio come Dio nel suo rapporto col mondo. Con ciò si
esce dal meccanismo governato dal «principe di questo mondo»,
perché, semplicemente, si esce da questo mondo[13]
Se Dio crea ogni
creatura e ciascuna è imago
dei,
in
visum dei,
allora l’esperienza della diversità, offerta dal disabile, è
contemplazione del Volto divino. Si tratta certamente di sentieri
interessanti e stimolanti, ma che conducono troppo lontano dalla
specificità del presente contributo.
Tornando al presente
argomento, emerge come considerare i disabili delle persone abbia
delle precise conseguenze, umane e sociali. Infatti, nella misura in
cui una comunità esiste perché esiste un suo diritto (ibi
ius, ibi societas),
come corpus
normativo, allora la società deve assumersi la responsabilità di
tutelare, e difendere ove occorresse, i diritti di questa categoria
sociale, e lo deve fare a maggior ragione in quanto essa è
particolarmente esposta ai soprusi. Le società umane si
caratterizzano per essere “imperi del diritto”, espressione di
una civiltà umana basata sui valori universali, e condivisi, di
«giustizia» e «rispetto».
La considerazione
della presenza di «diritti», in altri termini, comporta che la
società prenda
sul serio
tali diritti, e si regoli di conseguenza senza tentennamenti e/o
ostruzionismi[14].
Nella
misura in cui il disabile è colui che vive una esistenza limitata a
causa di un ambiente non adatto ai suoi bisogni particolari, è gioco
forza riconoscere, come proprio, compito di una società assicurargli
il rispetto dei suoi diritti
soggettivi,
diritti, per definizione, non disponibili alla contrattazione, e che
gli spettano in funzione del riconoscimento della sua particolare
condizione, la quale, però, va considerata non la causa di una
possibile discriminazione, quanto, piuttosto, l’illuminazione della
presenza di ben precisi bisogni “speciali”. Se ciò viene fatto,
allora è possibile riscattarne l’immagine e la considerazione in
seno al medesimo consesso civile. Ci si lagna, però, generalmente,
per via di un ben noto malcostume italico, che le tasse siano troppo
alte, e che sarebbe bene ridurle. Ma ridurre la spesa vuol dire anche
ridurre i servizi, proprio quel “terzo settore” di vitale
esigenza per le persone disabili. Tale atteggiamento trova oggi il
destro di una crisi economica la quale, ormai, serve a giustificare
qualsivoglia decisione politica e/o governativa, presa all’insegna
del “risparmio”. Tuttavia, in tutti questi casi si trascura un
fatto semplice e conseguente: i diritti, a dispetto di quanto
comunemente si possa pensare, non sono gratuiti, hanno un costo.
Ecco, allora, una conseguenza alla quale è bene che ci abituiamo,
vista la piega morale,
nel senso di costume,
assunta a livello continentale: “me ne frego dei bisogni altrui,
m’interessano le mie tasche”.
Infatti,
nella misura in cui prevale l’egoismo contributivo ci saranno alla
fine meno diritti per tutti. Solo che in questo caso il “tutti”
vuol dire che i più deboli pagheranno il prezzo maggiore. Motivi di
preoccupazione, al riguardo, suscita la recente politica federalista,
ove l’erogazione dei servizi verrà agganciata alla risorse
prodotte dal medesimo territorio. Molto brevemente, ciò significherà
che le persone disabili, in certi casi, saranno doppiamente
sfortunate: da un lato, nascono e vivono con ulteriori ostacoli al
completo sviluppo della loro personalità, e, dall’altro lato,
hanno anche la sfortuna di vivere in un territorio privo di risorse
adeguate a garantire loro servizi essenziali. Ciò basta a criticare
l’ottimismo di Bobbio: la tendenza attuale è contraria alla
direzione di progressiva estensione dei diritti[15].
Trattare
adeguatamente le persone disabili equivale a dare concreta
realizzazione alla mission
umanistica: dare corso a quel che sviluppa la personalità umana in
tutti si suoi aspetti, anche in quelli che possono apparire poco
nobili e/o degradanti ai nostri occhi.
Ciò vuol dire che,
per quanto la persecuzione dei diritti abbia un costo economico, dare
corso alla giustizia non ha prezzo in quanto essa è un bene non
disponibile alla contrattazione, ossia al cosiddetto valore
economico.
Altrimenti, cosa si
potrebbe rispondere ad una madre che, sconsolata, chiede «cosa
dovremmo fare allora con i nostri figli? Portarli nelle camere a
gas?».
D’altra parte, il
nesso tra la disabilità e la società è, come visto,
molto marcato. Infatti, la prima è una conseguenza della seconda nei
casi in cui quest’ultima non tiene conto della diversità, e non fa
nulla per aiutare i più deboli.
È anche vero,
comunque, e ciò a riprova degli esiti raggiunti nella presente
ricognizione, che una società umana si caratterizza proprio per la
sua vita culturale, la quale, per intenderci, ha una direzione
diametralmente opposta al principio biologico della “lotta per la
sopravvivenza”, detto anche del “gene egoista”, che fa
primeggiare la mera forza fisica e che, altrettanto chiaramente, non
ha nulla a che fare con i principi di giustizia.
(immagine tratta da: http://www.disabiliforum.com/prodotti/img/Misure_disabile.bmp)
Note
[1] Cfr. G.
Pontiggia, Nati due volte, Blibliotex, Barcellona, 2002, pp.
35 – 6.
[2] Cfr. A.
Canevaro, Pedagogia speciale. La riduzione dell’handicap,
Paravia Bruno Mondatori, Milano, 1999, p. 13 e sgg.
[3] Cfr. Comitato
Nazionale di Bioetica, Bioetica e riabilitazione, Roma, 17
Marzo 2006, p. 7.
[4] Cfr. L.
Trisciuzzi, Manuale di didattica per l’handicap,
Laterza, Roma – Bari, 20045, p. 228.
[5] Cfr. V. Mancuso,
Il dolore innocente. L’handicap, la natura, Dio, Mondadori,
Milano, 2008, pp. 41 – 42.
[6] Ger 1, 5.
[7] Gv, 1, 1 – 3.
[8] Cfr. V. Mancuso,
L’anima e il suo destino, Raffaello Cortina, Milano, 2007,
p. 9.
[9] Ivi, pp.
33 – 4.
[10] Gb, 42, 1 –
6.
[11] Cfr. V.
Mancuso, Il dolore innocente…cit., p. 187.
[12] Ivi,
p. 209.
[13]
Ibidem.
[14]
Cfr. R. Dworkin,
Taking Rights Seriously,
Duckworth, London, 1977, p. 205: «if the government does not take
rights seriously, then it does not take law seriously either».
[15]
Cfr. N. Bobbio, L’età dei diritti,
Einaudi, Torino, 1992.